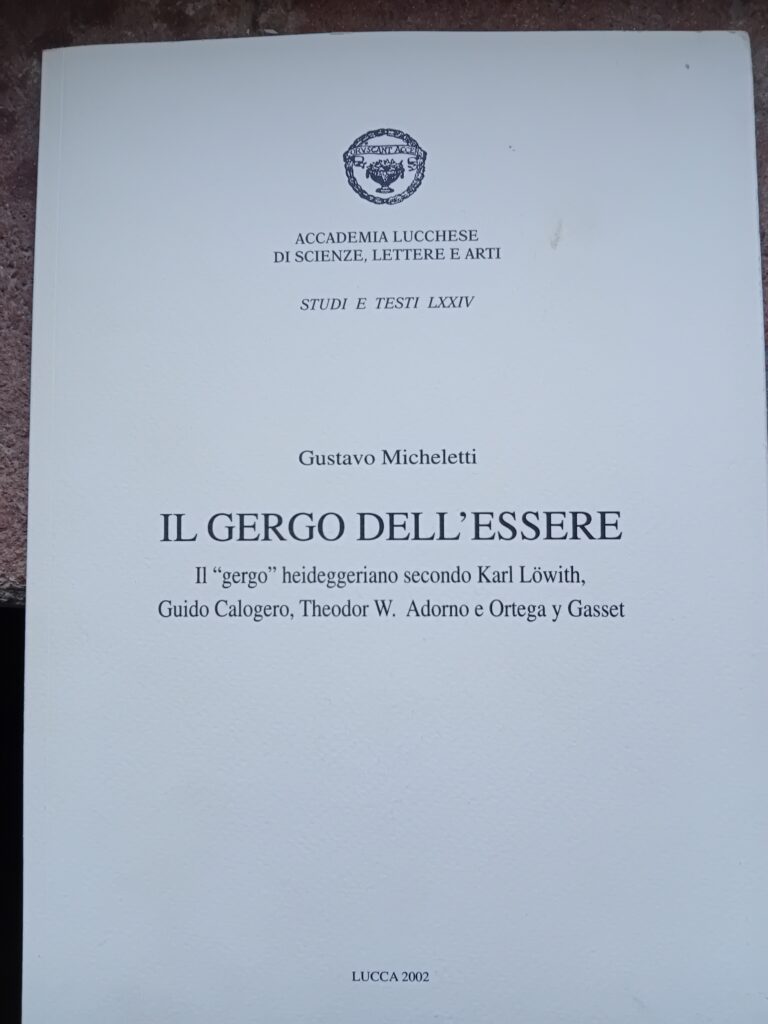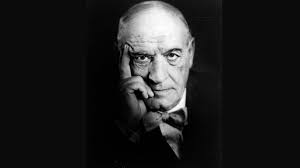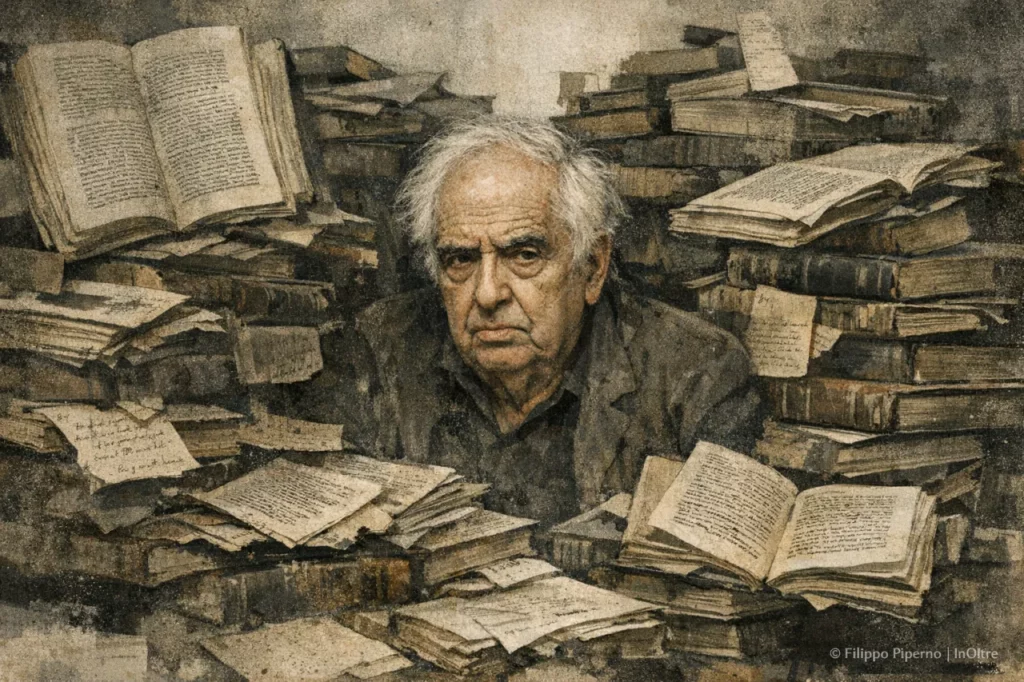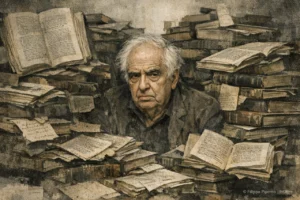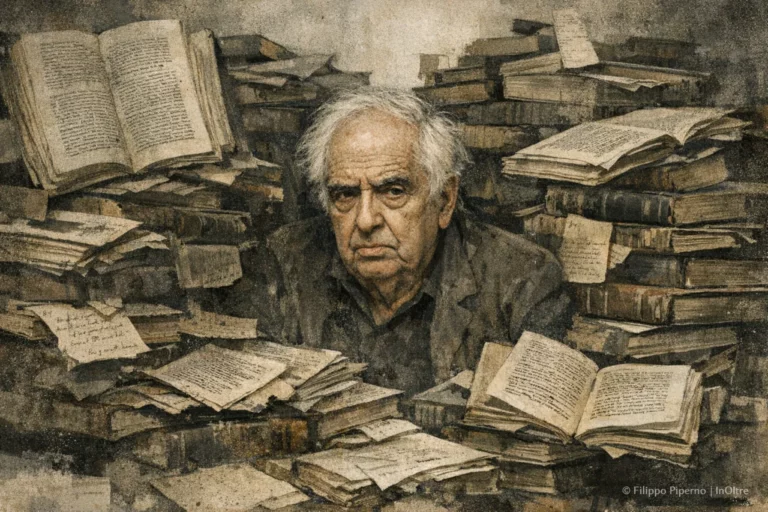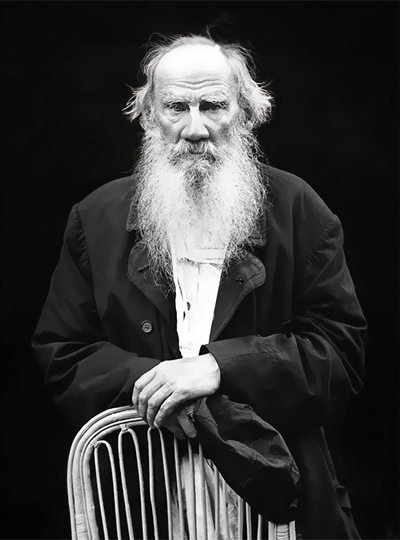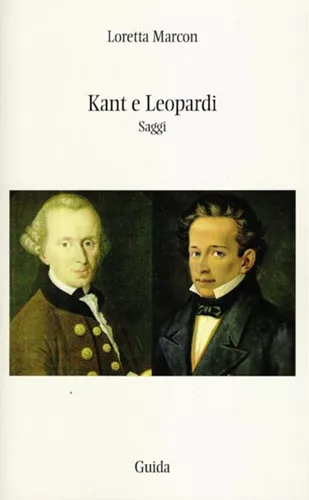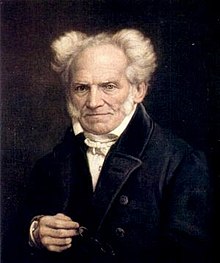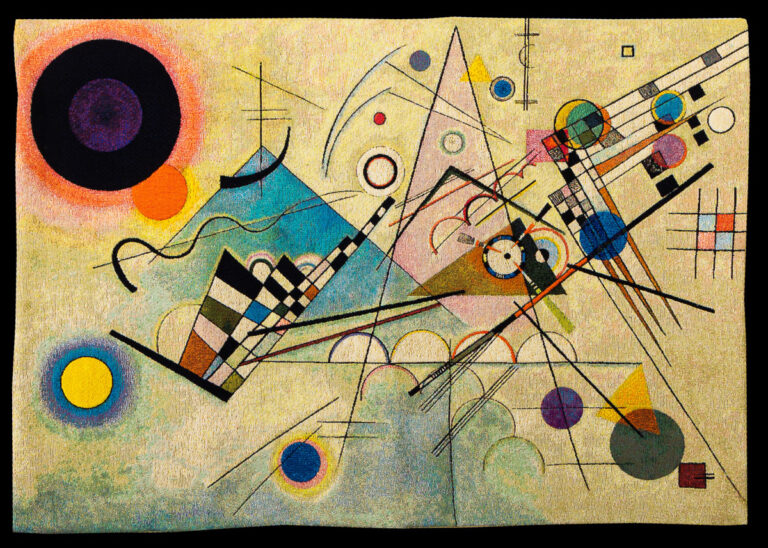https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/gustavo-micheletti-07
https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/gustavo-micheletti-01
https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/gustavo-micheletti-08
Qualche considerazione su Astrattismo, entropia e progresso “Nescis quid Vesper serus vehat” (Virgilio, Georgiche)...