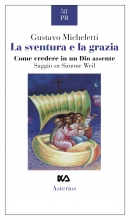-

-

Come un pupazzo a molla che salta da un ventre di legno, preda del desiderio di prendere ancora e sempre parte alla vita, o come un foglio accartocciato in un cestino e riaperto con circospezione per ritrovarvi le tracce di quanto non è mai accaduto, o “un sogno impalpabile di luce e di calore/che vaga tra l’erba e le piante del prato”, siamo alla fine questo stesso qualcuno afferrato da “una acuta ed inutile voglia” di sedersi per terra e di non fare più nulla per lasciarsi sorprendere dal proprio sguardo sul mondo. Si tratta solo di sapersi riconoscere in pochi momenti essenziali in cui si resta sospesi, in quei pochi smisurati istanti in cui la vita intera pare tirare le fila e disegnare un profilo nell’aria, il nostro o quello di uno sconosciuto, di quel pupazzo un po’ sinistro e ignoto che siamo, sogni di altri non meno ignoti, di un destino ridente che ci fa assomigliare ad un piccolo Dio con la sua aura di banalità che lo accompagna come un’ombra.
"Cantiamo ciò che non abbiamo": in questo verso, che dà anche il titolo a questa raccolta di poesie di Marco Giovannetti, sembra riecheggiare, come in un romanzo di Vittorio Saltini di un po’ di anni fa, un verso di Antonio Machado: "Se canta lo que che se pierde": quel che non abbiamo o abbiamo perduto è infatti ciò che rimane accartocciato nel cestino, è “l’angoscia di non poter urlare il nostro niente/come un ciclope accecato, irriso”.
Leggi tutto: Nei ripostigli del cuore, sentire le cose parlare
Il 7 novembre 2016 Mario Perniola, uno dei maggiori e più originali filosofi italiani dell'ultimo mezzo secolo nonché uno dei pochi ben conosciuti all'estero, ebbe dal suo medico una prognosi infausta: "un anno di vita. Non un mese di più, né un mese di meno".
Cosa accadde durante quell'anno Perniola lo racconta in un libro che è anche un testamento filosofico: Tiresia contro Edipo. Vita di un intellettuale disorganico (Il melangolo edizioni, Genova, 2021), libro che è essenzialmente il tentativo di decifrare il senso del proprio destino alla luce della propria malattia. S'ispira in tale tentativo all'idea stoica di amor fati, che Perniola definisce come "l'adesione incondizionata a ciò che è stato, a ciò che è, a ciò che sarà", e cioè a quella "riconoscenza nei confronti del nostro destino" che si concilia in lui con quel sentimento estetico che lo ha accompagnato durante tutta la vita.
Come osserva Enea Bianchi nella bella introduzione al volume da lui curato – gli stoici, per i quali la realtà è permeata dal logos, rintracciano la bellezza e il vero bene nel mondo e non in un mondo dietro al mondo". Rintracciare la bellezza nel mondo, saperla trovare nel proprio destino anche quando ci conduce all'incontro con Madame Morte, è uno dei principali motivi ricorrenti in questo libro, e poiché per farlo è necessario mettersi alla ricerca delle cause psicologiche del suo male a questo fine viene evocato Tiresia, il divinatore della tragedia di Edipo, proprio in quanto è ritenuto in grado di anticipare le cause psicologiche del male. E secondo l'autore, nel suo caso, l'origine del male è riconducibile al bisogno di essere visti.
Leggi tutto: Il sentimento estetico di un intellettuale disorganico
L’etichetta «made in China» non era stata ancora inventata, eppure la civiltà cinese esisteva già, ed era fiorente ed evoluta. Nemmeno il nome Cina non esisteva: sarebbe nato solo con la Qin che, appunto, si pronuncia cin. Si tratta di una dinastia che, come ricorda Federico Rampini nel suo ultimo saggio (Fermare Pechino: Capire la Cina per salvare l'Occidente, Mondadori editore), unifica sotto un’unica amministrazione gran parte del territorio cinese a partire dal 221 avanti Cristo. La terra della seta, che in seguito arriverà in Europa grazie a due monaci, e contrabbandieri, nestoriani, sarebbe poi divenuta, durante il medioevo e per merito di Marco Polo, il famoso Catai.
Non sono trascurabili i segni della presenza di tale civiltà all'arte occidentale: basti pensare all’Adorazione dei Magi dipinta da Giotto nella basilica inferiore di Assisi, in cui sono riconoscibili due personaggi cinesi, o a un affresco del Pisanello, San Giorgio e la principessa, che si trova nella chiesa di Sant’Anastasia a Verona, e in cui sono ben visibili due cavalieri dai tratti somatici asiatici, o ad alcune opere di Ambrogio Lorenzetti.
Ma soprattutto Rampini ci ricorda che Confucio è più antico di Machiavelli e che ha insegnato ai cinesi "il rispetto per l’istruzione, il senso delle gerarchie e delle regole, la venerazione per i padri, la capacità di anteporre la comunità all’individuo", tanto che lo ammirarono anche Voltaire e Montesquieu.
Sulla civiltà cinese ebbe però una grande influenza anche il buddismo, e con esso una sua certa idea del diavolo di cui ci ha trasmesso dei simboli: nel tardo medioevo, per esempio, il demonio veniva spesso raffigurato come un pipistrello, che assomiglia molto al dragone della tradizione cinese, tanto da poter suggerire l'ipotesi semiseria che il covid sia partito non per caso proprio dalla Cina, e dai pipistrelli.
Leggi tutto: Il dragone è sempre più vicino, e non è solo

L'opera pittorica di Christian Olivares
Christian Olivares nasce a Valdivia, in Cile, il 13 settembre del 1944 da padre cileno e madre danese, frequenta la Scuola di Belle Arti a Santiago e poi si perfeziona all'Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Durante la dittatura di Pinochet si mette in luce in Italia grazie a varie mostre collettive di artisti dissidenti cileni, mentre in seguito realizza mostre personali, oltre che nel suo paese d'origine, anche a Roma, Bologna e Berlino. Oggi risiede ad Amburgo, ma ha soggiornato a lungo anche in Italia, soprattutto a Bologna, a Roma e a Parma, dove ha collaborato come volontario all'ospedale psichiatrico di Colorno quando era diretto a Franco Basaglia. Sempre in Italia, e poi in Spagna, ha curato le scenografie di alcuni film di José Maria Sanchez. Ha inoltre realizzato le scenografie di alcuni spettacoli teatrali del regista cileno Raúl Ruiz Pino al festival di Avignone e della ballerina spagnola di flamenco María Pagés.
Nonostante questi pregressi, nel nostro paese è però conosciuto più per l'errore dei giudici che attribuirono un suo quadro a Pacciani, ovvero al "mostro di Firenze", piuttosto che per lo straordinario complesso della sua opera. Fu Vittorio Sgarbi ad avvertire giudici superficiali e frettolosi giornalisti che non poteva non trattarsi di un vero pittore, caratterizzato da una profonda conoscenza della storia dell'arte, assimilata e rielaborata in maniera originale.
Quella di Christian Olivares è infatti un'opera variegata di stili anche assai eterogenei ed evocativi di correnti artistiche diverse, da cui trapela costantemente una profonda cultura pittorica ed estetica. Una delle cifre stilistiche preminenti è una certa solitudine dei corpi, sorpresi spesso in un'espressione che li raccoglie, è una certa fierezza che traspare dagli sguardi e da certe espressioni dei volti, che sono spesso colti in momenti di silenzioso raccoglimento, quasi rivelando un'attitudine un po' buddista o taoista al non pensiero, al conseguimento di quel vuoto mentale che poi costituisce la massima forma di consapevolezza.
Leggi tutto: Dialogando in sogno con i maestri
Il presente e succinto promemoria parte dall'ipotesi che i "settari" siano una categoria psicologicamente, sociologicamente e culturalmente ben definibile, esattamente come i loro eterni contraltari, ovvero i "dialogici". Ma come si fa a distinguere, nella vita e su Twitter, gli uni dagli altri?
Prima differenza: i settari tendono ad asserire, i dialogici ad argomentare.
Seconda differenza: i settari tendono ad essere sempre d'accordo con il loro capo carismatico, o leader, mentre i dialogici talora sono critici anche verso le persone che apprezzano e stimano di più.
Terza differenza: i settari tendono a rispettare le gerarchie all'interno della loro setta; i dialogici, non identificandosi mai con alcuna setta, non hanno alcuna particolare soggezione verso qualsivoglia gerarchia.
Quarta differenza: i settari tendono a muoversi e agire in gruppo, i dialogici tendono a farlo da soli.
Quinta differenza: i settari sono inclini all'offesa, mentre i dialogici solitamente ne rifuggono.
Sesta differenza: su Twitter i settari tendono a mettere molti like, specialmente dove ce ne sono già tanti; i dialogici ne mettono in genere di meno, ma di più dove ce ne sono di meno.
Settima differenza: i settari tendono a non cambiare opinione, anche quando non ne hanno, come spesso accade, una propria; i dialogici tendono a cambiarla con circospezione.
Ottava differenza: i settari, identificandosi con la propria setta, hanno qualche difficoltà in più dei dialogici a provare vergogna, perché si appagano di surrettizie sicurezze gregarie.
Nona differenza: i settari, al contrario dei dialogici, sono per lo più incapaci di trarre un vero piacere dalla conversazione, mentre trovano soddisfazione nelle discussioni, specialmente se accese.
Decima differenza: sia nella vita sia su Twitter i settari tendono a ripetere all'infinito i luoghi comuni cari alla propria setta e talora, sbagliando coordinate, inavvertitamente anche ad altre concorrenti; ripetizioni da cui invece rifuggono i dialogici.
Uno dei massimi intellettuali e saggisti d'area liberale del Novecento, Isaiah Berlin, in un libro ormai classico pubblicato per la prima volta nel 1939 e uscito quest'anno in traduzione italiana per Adelphi a cura di Henry Hardy, definisce Karl Marx come "il vero padre della storiografia economica moderna e forse anche della sociologia moderna", almeno "nella misura in cui è possibile attribuire questo titolo a un'unica persona".
Tutta l'imponente e geniale architettura filosofica costruita da Marx potrebbe aver preso le mosse da un'idea enunciata in un verso di Rassegnazione da Friedrich Schiller: "la storia del mondo è la giustizia del mondo". Sul fatto che la storia proceda sempre verso una maggiore razionalizzazione della realtà lo storicismo hegeliano e quello di Marx secondo Berlin concordano: "la scissione nacque al momento di stabilire quale peso dovesse essere attribuito ai termini cruciali razionale e reale".
Com'è noto, uno dei motivi di discussione tra destra e sinistra hegeliana verte proprio sul diverso peso da attribuire alle due parti di una celebre formula di Hegel: "il reale è razionale e il razionale è reale". Mentre la destra tendeva a sottolineare la prima parte dell'affermazione, la sinistra metteva in risalto la seconda. La storia, in questa prospettiva, non poteva che consistere nella progressiva razionalizzazione della realtà, e cioè non poteva che progredire verso il superamento, in senso hegeliano, delle sue contraddizioni, e quindi, per Marx, del fatto che mentre la produzione, dopo la prima rivoluzione industriale, era diventata collettiva, la proprietà dei mezzi di produzione era rimasta in mani private. La Storia avrebbe provveduto a superare una tale contraddizione facendo in modo che i capitali si accumulassero nelle mani di un numero sempre più ristretto di persone, mentre un numero sempre maggiore sarebbe diventato sempre più povero. Una volta che fosse giunta a completa maturazione la contraddizione strutturale di partenza si sarebbe instaurata, in una prima fase, la dittatura del proletariato e poi il comunismo vero e proprio, ovvero la società senza classi.
Leggi tutto: Il Marx di Isaiah Berlin
I: La ringrazio ancora, Don Fabrizio, per avermi concesso quest'intervista, che inizio col porle una domanda che ho in serbo da tempo: lei ha affermato, all'interno dell'opera del suo discendente che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, che i siciliani non vogliono cambiare, non vogliono migliorare, perché in fondo presumono di essere perfetti, perché la loro vanità, ma anche il loro desiderio d'oblio, gli impediscono di desiderare o auspicare qualsiasi mutamento. Ritiene quindi che i problemi fondamentali della Sicilia, ma anche dell'Italia, visto che si tratta in buona parte degli stessi, siano problemi insolubili?
Principe: A quali problemi si riferisce?
I: Mi riferisco per esempio alle ampie sacche d'inefficienza e corruzione, alla burocrazia ipertrofica che le alimenta, ai molti giovani che anche per queste ragioni sono indotti a emigrare e al fatto che, nonostante alcuni successi nella lotta alla criminalità organizzata, le mafie continuano a prosperare come prima e più di prima.
Principe: Come ebbi già a dire al cavalier Chevalley, alla cui cortese offerta di un posto nel Senato del nuovo regno replicai illustrandogli le ragioni della mia disillusione, secondo me ormai è tardi per cambiare. Una volta che si è formata la crosta viene meno ogni reale intenzione di cambiamento. Per questo i giovani farebbero bene ad andarsene prima. Vede, nessun problema del genere è insolubile, ma tutti lo sono quando non si ha alcuna intenzione di affrontarli e risolverli. Prenda per esempio il problema della criminalità organizzata, visto che vi ha fatto cenno con la sua domanda: ma lei pensa veramente che se uno Stato moderno volesse realmente combatterla ed eliminarla in oltre un secolo non ci sarebbe riuscito?
Intervistatore (I): Non saprei, secondo lei?
Principe: Nessun Stato moderno discretamente efficiente e realmente democratico è impotente verso le mafie: può trovarsi a gestire con qualche difficoltà questi fenomeni per qualche periodo di tempo, ma poi ne viene a capo. Diverso è il caso quando la criminalità organizzata ha avuto modo di diventare per fatturato di gran lunga la prima azienda di un paese. Quale Stato potrebbe mai avere interesse a smantellare un'impresa simile? Quale potrebbe trovare la forza e la determinazione per farlo? Ha idea del contraccolpo economico, e dunque anche politico, che una simile operazione comporterebbe?
I: Immagino un notevole danno economico, e di riflesso magari anche politico. In effetti la criminalità organizzata è di gran lunga la prima azienda italiana. Se non ricordo male la sola Ndrangheta è la quarta organizzazione di stampo mafioso nel mondo, con circa settanta miliardi di fatturato.
Leggi tutto: Un'intervista al Principe di Salina sull'Italia di oggi
Karl Popper riteneva che le regole fondamentali del metodo scientifico non fossero molto diverse da quelle della democrazia. Così come una teoria scientifica, per poter essere considerata tale, deve essere falsificabile, analogamente in democrazia chi viene eletto dal popolo per governare deve sottoporre il suo operato politico al giudizio del popolo e deve poter essere sostituito qualora il popolo ritenga che abbia governato male. Sia le teorie scientifiche, sia chi è stato eletto dai cittadini a ricoprire qualche carica politica deve sottoporsi alla controprova dell’esperienza e della storia. Così come una teoria che non ammette la possibilità di essere falsificata e non indica in quali circostanze potrebbe esserlo non è scientifica, così una società in cui chi governa non sottopone il proprio operato al giudizio degli elettori, nei tempi e modi previsti dalla legge, non è democratica.
Il marxismo è, secondo Popper, un tipico esempio di teoria non scientifica, in quanto non ha mai ammesso di poter essere falsificata dalle circostanze storiche che hanno smentito le sue previsioni. Trattandosi di una teoria imponente, che è riuscita a operare una sintesi poderosa e coerente tra l’idealismo dialettico di Hegel, il materialismo di Feuerbach, il pensiero degli economisti classici e anche un certo alone di scientismo positivista, ha egemonizzato l’ampio e articolato movimento che da ormai oltre mezzo secolo si stava battendo per realizzare una società che fosse più giusta oltre che più libera.
Leggi tutto: Popper, Croce e le insidie di un paragone ellittico
Intorno a La fragilità del male di Dietrich Bonhoeffer.
“Chi ama non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,” si legge nella Prima lettera ai Corinzi (13:5), e Dietrich Bonhoeffer, ne La fragilità del male, prende spunto da questo passo per osservare che, mentre la giustizia sembra illuminarci la strada “determinando il bene e il male, l’amore al contrario è cieco, consapevolmente cieco. Vede il male, ma non ne tiene conto: perdona. Soltanto l’amore può farlo. Dimentica. Non serba rancore”. Questo costituisce a suo avviso, e certo non solo per lui, un punto centrale per il cristianesimo: “se solo comprendessimo questo concetto: l’amore non serba rancore. Ogni giorno è un giorno nuovo che affronta con rinnovato sentimento, dimenticando il passato. Per questo motivo gli uomini si fanno beffe di lui, lo scherniscono. E nonostante questo continua ad accrescersi sempre di più”.
Gesù dice anche a Pietro di perdonare non “fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette” (Matteo, 18: 21-22) e ciò perché “perdonare e scusare non sono azioni che si contano o che hanno un limite. Non preoccuparti se hai ragione oppure no. Spetta a Dio decidere. Tu puoi farlo senza fine, perché il perdono non ha inizio e non ha termine. Si verifica quotidianamente e di continuo, perché proviene dal Signore. È la liberazione da ogni ostilità nei confronti del prossimo, perché così siamo liberati da noi stessi. Dobbiamo rinunciare al nostro proprio diritto per aiutare e servire l’altro”.
Leggi tutto: Pentimento e perdono
Piero Martinetti e Simone Weil sono morti entrambi nel 1943 e si può presumere che ignorassero reciprocamente le loro opere. Ebbero entrambi atteggiamenti pubblici intransigenti verso il fascismo e il nazismo: la Weil tornò appositamente in Europa dagli Stati Uniti per combattere Hitler e Martinetti fu l’unico filosofo tra la dozzina di professori che su 1200 accademici italiani si rifiutò di prestare giuramento al regime. Inoltre, entrambi mostrarono qualche simpatia per il marcionismo.
Marcione di Sinope fu un eretico della metà del secondo secolo che considerava il Vecchio Testamento come il prodotto di un Dio che aveva tutti i pregi e i difetti dell’umanità e la cui legge risultava da una miscellanea di giustizia e di arbitrio, di amore e odio. Il Messia che aveva promesso non era mai giunto sulla terra, mentre un altro Dio, quello che aveva ispirato i primi tre vangeli, aveva mandato suo Figlio, Gesù Cristo, nel mondo per liberare gli uomini dagli effetti della materia e della legge di quel primo Dio.
Secondo la lettura che viene fornita da Ernst Bloch, Marcione fu colui che “cercò di strappare radicalmente Gesù dal quadro biblico-giudaico durato fino ad allora. E ciò avvenne, notiamolo bene, senza una qualsiasi tensione o inimicizia verso i Giudei (Marcione venerava il giudeo Paolo come il suo maestro); ma nulla Gesù aveva in comune con la Bibbia di Jahvé fintanto che essa rimane tale. Marcione non solo poneva il messaggio di Cristo in contrapposizione con l’Antico Testamento, ma ne faceva qualcosa di assolutamente diverso; la rottura con l’Antico segue dunque al salto dell’Evangelo nel nuovo che appare senza confronti. In tal modo è in primo luogo a partire da Marcione che si è sviluppato ed è stato posto in risalto in genere il concetto di un Nuovo Testamento” (E. Bloch, Ateismo nel cristianesimo, trad. it. Milano, 1971; ed. cit. 1983, p. 227).
Leggi tutto: Piero Martinetti, Simone Weil e l'attualità del marcionismo
Il proposito di coniugare gli ideali di libertà e di giustizia, riproposto con alterne fortune da oltre due secoli, è sembrato erroneo, vano o improbabile tanto a molti liberali quanto a molti socialisti. Se per quelli che lo hanno adottato le sconfitte politiche sono state più frequenti delle vittorie, tuttavia nel lungo periodo non si può non registrare una crescita in parallelo sia del socialismo riformista e liberale rispetto a quello massimalista e terzo-internazionalista, sia di un liberalismo sempre più spesso temperato da correttivi volti a favorire una ridistribuzione complessiva della ricchezza.
Nonostante le dispute che coinvolsero socialisti liberali o liberalsocialisti come Aldo e Nello Rosselli, Piero Calamandrei, Gaetano Salvemini, Aldo Capitini, Guido Calogero, Ernesto Rossi, Norberto Bobbio e molti altri, il loro tentativo di dare vita a un tipo di società che cercasse di coniugare in maniera efficace i valori della libertà e della giustizia è stato recepito dai padri costituenti, che ne hanno fatto due riferimenti cruciali della carta costituzionale. Alle riserve di Benedetto Croce circa la commistione di due principi a suo avviso eterogenei come quelli di libertà e di giustizia, rispose poi nel merito Guido Calogero, secondo il quale l’ideale di giustizia – che non significa ugualitarismo economico o sociale, ma l’impegno delle comunità a garantire ad ogni cittadino una dignità sociale e una disponibilità economica idonee a esercitare quelle libertà fondamentali altrimenti destinate a restare astrazioni sulla carta dei diritti – è fondamentale per la realizzazione di una vera uguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali previsti dallo Stato liberale: “la civiltà – scriveva infatti Calogero – tanto meglio procede quanto più la coscienza e gli istituti del liberalismo lavorano ad inventare e a instaurare sempre più giusti assetti sociali, e la coscienza e gli istituti del socialismo a rendere sempre più possibile e intensa e diffusa tale opera di libertà”.
Oggi le differenze tra destra e sinistra non consistono più, come un secolo fa, nel proporre due strutture diverse ed opposte della società (in base alla presenza o assenza della proprietà privata dei mezzi di produzione), ma sono più che altro riconducibili a dosaggi diversi dell’intervento dello Stato nell’economia. Dopo John Maynard Keynes non è affatto detto che anche un governo a guida liberale non ritenga opportune misure di welfare più o meno permanenti: una certa giustizia distributiva, infatti, non ha solo l’effetto di realizzare un ideale di tipo etico-politico, ma anche quello di rendere la società meno conflittuale e dunque più efficiente e produttiva, nonché quello, non secondario, di favorire la crescita della domanda interna, con tutto ciò che può seguirne in termini di ricaduta sull’offerta e sui livelli occupazionali.
Leggi tutto: Il coefficiente di Gini e un'idea liberale di giustizia
Era da pochi mesi finita la prima mondiale quando Ernesto Rossi conobbe Gaetano Salvemini. Fu una domenica a Firenze, in una saletta nei pressi del cimitero degli inglesi in cui lui ed altri si erano ritrovati per discutere di sistemi elettorali. C’erano una cinquantina di persone, per lo più collaboratori o lettori dell’Unità, la rivista che Salvemini diresse dal 1911 al 1920.
In quella saletta un tizio stava parlando in mezzo a una gran confusione e continuò a parlare per più di un’ora. Alla fine del suo discorso nessuno ci aveva capito nulla e quando Salvemini prese la parola iniziò il suo intervento così: “l’amico che abbiamo ora ascoltato, ha detto che…” e a poco a poco – racconta Rossi - “fu come se, in un treno che è stato trascinato a lungo sotto la pioggia da una sbuffante macchina a vapore, qualcuno strusciasse col fazzoletto pulito sul vetro del finestrino sporco di fuliggine. Parlava ed il vetro diveniva sempre più limpido, e sempre più chiaro si vedeva il paesaggio fino al lontano orizzonte. Dopo avere riassunto non quello che aveva detto, ma quello che avrebbe dovuto dire il precedente oratore, Salvemini prese a sviluppare il filo delle sue deduzioni. Con una logica così semplice e così rigorosa che non sarebbe stato possibile non capire. Alla fine della sua esposizione il sistema della rappresentanza proporzionale, che prima ci sembrava un terribile rompicapo, era divenuto la cosa più semplice del mondo”. Allora, rivolto chi gli sedeva accanto, Rossi commentò: “per un intellettuale, chiarezza equivale ad onestà”.
I primi passi dell’amicizia tra Rossi e Salvemini furono piuttosto difficili. Quando si conobbero Rossi aveva ventidue anni e nessuna esperienza politica: “ero andato al fronte – scrive - come volontario di guerra, non per Trento e Trieste, ma per impedire che il militarismo tedesco soffocasse, per tutta un’epoca, la libertà in Europa. Durante l’ora della cosiddetta ‘morale’, avevo letto e spiegato ai miei soldati I doveri dell’uomo di Mazzini. Tornato a Firenze, mutilato, non potevo ammettere che tutte le sofferenze patite e il sacrificio di tante giovani vite (avevo perduto al fronte anche mio fratello maggiore e i miei due migliori amici) venissero vilipesi dai socialisti, che erano stati in gran parte imboscati nelle fabbriche d’armi, e che, fino a Caporetto, avevano adottato la vile politica del <<non collaborare, né sabotare>>”.
Leggi tutto: Un maestro e un amico. Ernesto Rossi e il suo ritratto di Gaetano Salvemini
Difficile dire perché dei versi siano poesia. Difficile oggi forse più che mai prima, per il proliferare di gusti e scritture, di gesti artistici d’ogni tipo supportati da letture critiche lusinghiere verso un diffuso concettualismo o uno sperimentalismo enfatico. Difficile, se non impossibile, spiegare oggi perché una raccolta poetica possa stagliarsi sullo sfondo delle opinioni facili di questi tempi, in questo scorcio malato d’inizio millennio. L’unica possibilità residua è forse aggiungerne una alla lunga lista, una non meno approssimativa e incerta di ogni altra, che in null’altro ricerchi un fondamento se non nel lasciar risuonare i versi, nell’affabularli per un minuto o due sperando che tocchino l’anima di qualche impenitente lettore di poesia. Nonostante tutto, c’è infatti chi ha ancora il gusto di cercare, in questa forma d’arte letteraria, tracce di vita in grado di far senso, di produrre la luce e l’orizzonte più propri in cui poter riconoscere il proprio sguardo.
L’autore della silloge di poesia di cui ci apprestiamo a parlare è Bonifazio Mattei: un insegnante di lettere in un liceo classico romano, dantista per vocazione ed elezione. In qualità di dantista era solito tenere nelle sere d’estate, almeno fino a qualche tempo fa, delle letture/conferenze a Leonessa, nel reatino, aperte a tutta la cittadinanza interessata.
Nelle sue poesie si sentono gli echi degli autori a lui più cari: da Giacomo Leopardi a Giovanni Pascoli, da Camillo Sbarbaro a Giorgio Caproni, fino a Jorge Luis Borges o a Eugenio Montale, a Sandro Penna e a Umberto Saba. Dopo alcune poesie apparse in Erba d’Arno e in Poeti e poesia, con L’ultima casa, fa il suo esordio con una silloge nel panorama poetico italiano.
Leggi tutto: Una casa nuova e antica, per la poesia
Le riflessioni Nikolaj Berdjaev sul destino della democrazia in Russia
“L'individualismo, l'atomizzazione della società, la sfrenata concupiscenza mondana, la sovrappopolazione illimitata e la smodata pletora dei bisogni”: sono questi, secondo Nikolaj Berdiaev, gli ingredienti principali del materialismo economico, per il quale la vita spirituale dell'uomo è un’illusione priva di valore. Il socialismo, d’altro canto, non fa che sviluppare e portare alle estreme conseguenze questa prospettiva materialistica e non rappresenta in fondo che “il trionfo vivo dei suoi principi latenti e la loro piena diffusione”. Esso mutua “dalla società borghese capitalista il suo materialismo, il suo ateismo, i suoi lumi superficiali, la sua ostilità nei confronti dello spirito e di ogni vita spirituale, la sua frenesia di vivere e di godere, la sua lotta per gli interessi egoisti, la sua incapacità di concentrazione interiore”.
Nicolaj Berdiaev è stato uno dei più brillanti filosofi e critici letterari russo-ucraini del Novecento. In Nuovo Medioevo – il saggio che, uscito nel 1923, gli conferì notorietà internazionale - spiega perché dopo il trionfo di due varianti solo apparentemente opposte dello stesso modello culturale materialistico non possa che profilarsi l’esigenza di un nuovo medioevo, per il quale tornerà ad essere sostanziale ciò che nei tempi moderni viene invece considerato superfluo. In questa nuova epoca della civiltà si potrà infatti tornare “a un tipo religioso più elevato” e a rivalutare la sfera spirituale come l’unica possibilità per opporsi all’attuale decadenza.
A uscire da quest’epoca di decadenza il bolscevismo ci ha provato, ma non c’è riuscito, perché partiva dagli stessi presupposti materialisti che intendeva superare. Essendo una “allucinazione dello spirito” poté conquistare il potere perché corrispondeva in quel momento allo stato morale malato del popolo russo, esprimeva “esteriormente la sua crisi morale interna, l'abbandono della fede, la crisi della religione”. Per cercare di far fronte a simili malattie morali la democrazia liberale non poteva essere di alcun aiuto, e nemmeno il socialismo liberale e umanitario. Solo i bolscevichi potevano dar vita a un tipo di regime che fosse espressione del “singolare sentimento di distacco dalle cose terrene” che il popolo russo ha sempre manifestato e che è sconosciuto ai popoli dell'Occidente. Il popolo russo, infatti, “non si è mai sentito legato alle cose della terra, alla proprietà, alla famiglia”, e più in generale non si è mai sentito legato alla nozione stessa di diritto e di cittadinanza. La stessa religione ortodossa ha sempre valorizzato “l'idea del dovere, non l'idea del diritto”. I diritti della borghesia non hanno mai avuto presso il popolo russo una grande rilevanza.
Leggi tutto: Verso un nuovo medievo
È la purezza del dolore che genera la poesia. Nessuna poesia potrebbe aver mai avuto luogo senza l’ombra del dolore necessario a far risuonare l’eco delle sue parole. E la morte, si sa, è maestra nel generare dolore. La principale, e l’ultima, che non lascia spazio a ulteriori infingimenti, non a menzogne o a diatribe.
La morte è sempre la morte di qualcun altro, come dice Heidegger, e quindi noi siamo condannati a poterne fare esperienza solo per interposta persona, ma in qualche caso la morte di un’altra persona può essere tanto devastante da trasfigurare completamente il senso della nostra presenza del mondo, oppure da renderlo ancor più riconoscibile e nitido, come prima, forse, non era mai stato possibile coglierlo. Nella misura in cui ci siamo rapportati al mondo e agli altri in modo trasparente, l’unica morte che ci è concesso di vivere può purificare e rendere limpido ogni sentimento che durante la vita precedente sia rimasto, anche solo in parte, sospeso o indecifrato.
Ma la morte è anche apparenza, mancanza di sostanza, non essere per eccellenza. Una metamorfosi sommessa, un dileguarsi nel nulla per farsi eterni, per trovare nel nulla la propria consistenza definitiva. Come scrive Fernando Pessoa in una poesia, è un momentaneo sottrarsi allo sguardo, un divenire invisibili per un tempo imprecisato: “La morte è la curva della strada, / morire è solo non essere visto. / Se ascolto, sento i tuoi passi / esistere come io esisto. / La terra è fatta di cielo. / Non ha nido la menzogna. / Mai nessuno s’è smarrito. / Tutto è verità e passaggio”.
Leggi tutto: Un cuore pieno di simboli... nel diario d'un istante
Tre anni prima del suo rientro definitivo in Germania dagli Stati Uniti, nel 1950, Thomas Mann tenne a Chicago una conferenza con un titolo semplice ed emblematico: Il mio tempo. La traduzione italiana della conferenza, di Ervino Pocar, è contenuta in un volume della vecchia Medusa mondadoriana nel contesto di una silloge per la cui composizione lo stesso Mann ebbe occasione di compiacersi con l’editore italiano (T. Mann, Il mio tempo, in Romanzo di un romanzo, trad. it. Mondadori, 1952, pp. 241-265).
Il tempo in cui il grande scrittore tedesco si trovò a vivere, e di cui parlò in quella conferenza, è ancora quello dell’epoca che Goethe aveva già contrassegnato come l’era delle “facilità”, e che Mann assimila all’ “epoca della tecnica, del progresso e delle masse, quell’epoca che dopo una corsa di 120 anni è giunta in questi giorni angosciati a toccare la vetta vertiginosa e veramente fantastica” (ivi, p. 243).
La vetta cui Thomas Mann si riferisce è quella caratterizzata dal secondo conflitto mondiale, dall’olocausto e dall’incipiente guerra fredda, ma anche dal rapido diffondersi di quelle “mode” e correnti culturali che lui non seguì mai: “quando il mio pensiero ritorna al passato… – scrive infatti – ecco, io non ho mai seguito la moda, non ho mai portato il macabro martello dell’Arlecchino fin de siécle, mai avuto l’ambizione di essere all’avanguardia letteraria, mai appartenuto a una scuola o alla consorteria che era di volta in volta al comando, né al naturalismo, né al neo-romanticismo, al neo-classicismo, al simbolismo, all’espressionismo, e chi più ne ha più ne metta. Perciò non fui mai sostenuto da nessuna scuola e raramente lodato dai letterati (ivi, p. 251)”.
Leggi tutto: Thomas Mann e i moderati nell'era della tecnica
Autore:
Come credere in un Dio assente. Saggio su Simone Weil
Dio assente per un certo tempo.
Nessun filosofo può sottrarsi al rischio di rimanere preda dei paradossi che arriva a vedere e pensare, al rischio di esplodere in volo un attimo dopo averli sfiorati con le proprie ali. Come Kierkegaard testimonia – e come Jean Luc Marion sottolinea – “un pensatore senza paradosso è come l’amante senza passione, pura mediocrità”.
Il pensiero di Simone Weil non può che sottrarsi a qualsiasi sospetto in tal senso: la sua idea di Dio propone paradossi incalzanti cui la sua stessa vita rimase a lungo sospesa e il fatto stesso che per lei Dio possa manifestarsi solo tramite la sua assenza risulta fondamentale per poter comprendere il suo rapporto con la fede cristiana.
L’esperienza della «sventura» ha proprio la prerogativa di rendere “Dio assente per un certo tempo”, un tempo in cui, tuttavia, “bisogna che l’anima continui ad amare a vuoto, o almeno a voler amare, seppure con una parte infinitesimale di se stessa. Allora un giorno Dio le si mostrerà e le svelerà la bellezza del mondo, come accade a Giobbe”.
La sventura è per la Weil un dispositivo semplice: raduna tutto il male e lo raccoglie in un unico punto per trasfigurare il dolore di cui un essere umano è capace in una dimensione «impersonale», quella stessa in cui in definitiva si manifesta la grazia. Solo attraverso la sventura Dio può rivelarsi come il riflesso infinito della propria assenza; e amare Dio attraverso l’esperienza della sua assenza costituisce l'unica garanzia che abbiamo per poter coltivare una fede non idolatrica, una fede che sia in grado di trasfigurarsi nella testimonianza diretta e piena della sua presenza.
http://www.asterios.it/catalogo/la-sventura-e-la-grazia
(… e come fare per riconoscere i componenti del secondo).
Il primo partito non è mai una realtà monolitica, ma è da sempre composto da diverse correnti. Queste possono dar vita a un partito unico perché, nonostante le loro divergenze superficiali o apparenti, condividono le seguenti caratteristiche: 1) Sono solite autopromuoversi attraverso slogan piuttosto che attraverso argomentazioni; 2) Non sono solite trarre le conseguenze che sarebbe ragionevole aspettarsi dalle loro analisi o proposte né assumere la responsabilità delle proprie affermazioni; 3) Sembrano condividere con Hobbes la convinzione che la democrazia sia essenzialmente un’aristocrazia di oratori e tendono a considerare i cittadini votanti come dei meri strumenti di potere. In altri termini, come degli sciocchi facilmente manipolabili.
Alla luce di queste osservazioni, sarebbe dunque preferibile non votare per il primo partito e scegliere invece di votare per il secondo. Questo, purtroppo, è da sempre minoritario, in quanto composto dall’esiguo numero di persone che quando avanzano delle proposte per risolvere problemi o affrontare situazioni difficili non cercano di nascondere ai cittadini le relative difficoltà, ma anzi le illustrano a dovere mettendole bene in evidenza. Questo secondo partito è composto dunque da persone indipendenti, che amano tenersi alla larga dal primo partito e la cui influenza sul dibattito politico è pressoché irrilevante, in quanto le loro analisi sono scomode e loro proposte impopolari.
Leggi tutto: Perché non bisogna votare per il primo partito
Qual è l’habitat politico migliore per il capitalismo?
La repubblica popolare cinese è oggi il paese che ha la migliore crescita economica del mondo, ma è anche il primo paese al mondo a far registrare un così rapido sviluppo economico senza che sia stato raggiunto un elevato reddito pro capite. La sua economia è cresciuta più grazie alle esportazioni che ad una crescita corrispettivamente proporzionata della domanda interna. Ha ormai un ruolo fondamentale nel commercio internazionale e possiede enormi riserve in valuta estera; si sta comprando l’Africa e può vantare il maggior numero di miliardari al mondo, e tuttavia viene ancora per lo più considerata, e si considera, uno Stato comunista. In effetti non ha mai rinnegato, almeno formalmente, il suo passato, i cui simboli sono ancora presenti nelle sue strade o piazze, così come sulla sua bandiera.
Oggi la Cina è anche il paese che – come fa notare Jared Dianond nel suo libro apocalittico Collapse (2005) e come evidenzia Peter Hugh Nolan, direttore del Centro studi sullo sviluppo presso l’Università di Cambridge e membro del Jusus College, oltre che direttore del Chinese Executive Leadership Program (Celp) – “contribuisce maggiormente all’emissione nell’atmosfera di clorofluorocarburi, di altre sostanze nocive per l’ozono e (tra poco tempo) di anidride carbonica; le sue polveri e gli agenti inquinanti dell’aria vengono trasportati nell’atmosfera verso est nei paesi vicini e anche nel Nord America; inoltre è uno dei due principali importatori di legname della foresta pluviale tropicale, cosa che la rende un fattore di primo piano nella deforestazione dei tropici”.
Leggi tutto: Un dragone per tutte le stagioni

I personaggi de La luce tra l'erba, che sono anche i suoi narratori,
sembrano animati dal desiderio di perdersi per poi ritrovarsi.
Le loro vite s’incrociano a Firenze, a Milano, a Roma, e
ancora a Praga e in Bretannia, a Parigi e New York, ma vi sono
echi della permanenza di qualcuno di loro anche a Madrid e in
Patagonia, a S.Pietroburgo e nelle isole Solovki, dove ancora
s’avverte l’alone della presenza di Pavel Florenskij.
Il narratore centrale, l’unico senza nome e in certo qual modo
“senza qualità”, può così tessere la sua tela tra luoghi evocativi
e simbolici, illuminando con lo sguardo della sua memoria
i resoconti di personaggi che, come altrettanti alberi lungo il
declivio di un rilievo erboso, sembrano allungare, verso la fine
della vicenda che li lega, le loro ombre una di fianco all’altra, sul
far della sera.
"Un racconto di sradicamento, malinconico e avviluppante",
Raffaele La Capria
http://www.portoseguroeditore.com/product/la-luce-tra-lerba/